IL CATARISMO
La setta catara fu l’eresia più importante e diffusa in tutto l’occidente cristiano: fu quella per cui è stata istituita l’inquisizione, frutto della reazione decisa da parte della Chiesa. Fu un ricco movimento, non sempre coerente ed uniforme, che attraversò un lungo spazio di tempo, a cui partecipò un’ampia fascia della società medievale. Contrariamente a quanto si è scritto, l’eresia catara dei secoli XI-XII non fu un risveglio dell’antica dottrina della gnosi, o del manicheismo, ma, pur dualista, rimase sempre nell’ambito del cristianesimo. La loro interpretazione dualisticamente, o poco, aveva del dualismo cosmogonico e metafisico dei manichei e della dottrina di Mani (nei testi catari che sono giunti fino a noi è assente ogni riferimento a testi o comunque a insegnamenti manichei). Il loro era, piuttosto, un dualismo antropologico, dovuto ad una interpretazione particolare delle Scritture neotestamentarie, riferendosi specialmente alle lettere di S.Paolo e al Vangelo di Matteo, costantemente invocate dagli eretici come vere e proprie auctoritates, fonti d'ispirazione di tutta la loro dottrina morale e religiosa. Non a caso i Catari erano soliti chiamarsi Christiani o Boni Christiani (o anche Boni Homines), accettavano il Nuovo Testamento, e credevano nell'esistenza di due principi contrapposti, il Bene ed il Male, rappresentati rispettivamente dal Dio santo e giusto, descritto nel Nuovo Testamento e padre di Cristo, autore di tutte le cose buone ed eterne, e dal Dio malvagio, o Satana, responsabile delle cose visibili e transitorie.
CATARI A NORBELLO (Or)
La Santa Maria di Norbello (seconda metà del XII sec.), mostra nella tecnica costruttiva di dipendere dalla chiesa di Santa Maria di Bonarcado (prima metà del XII sec.; 1242-68), affiliata alla badia camaldolese di San Zenone di Pisa.

Le fondamenta della Santa Maria della Mercede di Norbehlo sfruttano in parte tombe bizantine, una delle quali (VII sec.) ha restituito un ricco corredo funebre. La nzione t’vr della chiesetta è testimoniata in epoca successiva; ricordiamo che anche le prime chiese tem ìtpl’ i ad aula unica, piccoli oratori, avevano questa funzione.. L’edificio, di piccole dimensioni, a ‘ipasr come una cappella privata, un oratorio; l’aula è mononavata con abside a nord-est, a copest’ iv lii nea, i p amenti esterni in basalto non mostrano nessuna decorazione.
La chiesa è citata per la prima volta in un atto del Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, vi si nomina un serba de sancta Maria de Norgillo e un prebiteru de Norgillo. Il documento è databile fra il 1164 e il 1174: "Coiuvedi Greca Pasi, ankilla de sanctu Iorgi de Calcaria cun Terico de Paule serba de sancta Maria de Norgillo. Fegerunt II fiios: Goantine et Maria. Levedi sancta Maria de Norgillo a Goantine et le vedi sanctu Jorgi de Calcaria ad Maria, piagendolli ad donnu Iorgi Carru, prebiteru de Norgillo. Testes: donnu Iorgi Capay et donnu Petru, su fradi, et donnu Terico Pala et donnu Zerkis Capai".
Il documento, annotato dal priore di Bonarcado, Johanne Mellone, attesta lo sposalizio d.eil’ ancella Greca Fasi, dipendente dal San Giorgio di Calcaria, con Terico de Paule, servo di Santa Maria di Norgillo. Sono gli anni in cui Comita de Martis è arcivescovo ti’ Arborea e Pietro, figlio di Bamsone i, è temporaneamente giudice, in quanto il padre è prigioniero a Genova6 Del 1229 è, invece, un atto che menziona, fra i testimoni, Barusone Pinna e Dorgotori de Sogos, curatore di Norghillos.
Il primo documento inquadra cronologicamente la chiesetta, il secondo è stato chiamato in at sa da alcuni studiosi i qu i hanno supposto che per via del divaricamento dei fianchi dell’edificio (dovuto alla mancanza di paraste angolari), si sia realizzato un intervento di restauro; inten tento che, databile intorno ai 1229, sarebbe testimoniato da un iscrizione dipinta, assieme a clipei crociati, all’interno della chiesa, e in cui si nominerebbero Barusone Pinna e Dorgotori de Sogos.
A questa decorazione vengono assimilate le pitture a motivi geometrici venute alla luce in frammenti di intonaco esistenti nella chiesa di San Basilio, nell’omonimo Comune. La chiesa, a due navate, è attestata per la prima volta nel 1219 e sorge su un’area cimiteriale con tombe a camera di età bizantina, alcune delle quali conservano le citate pitture. Nel recinto cimiteriale si conservano gli avanzi di uno stabilimento termale, forse di epoca tardo-romana. In uno dei vani, trasformato in cappella Aam rupestre dai monaci basihiani di culto bizantino, il soffitto presenta, dipinti in rosso, motivi simbolici cristiani, stelle ed altri9.

In realtà, a Norbello, due iscrizioni sono poste nel fianco interno nord e una in quello sud della chiesa, oggi purtroppo frammentarie e lacunose. In queste, dipinte in rosso a 1,60 in. di altezza, sull’intonaco che ricopriva le pareti, figurano i nomi di Barusone Pinna (due volte) e Vorgotori-Dorgotorio Pinna (due volte). Si è ipotizzato che il primo fosse quello ricordato nell’atto del Condaghe diBonarcado (1229); così come il secondo che però, nelle iscrizioni non figura come Dorgotori de Sogos (curatore di Norbello), ma come Dorgotorio Pinna 10
All’interno della chiesa, per tutta la lunghezza delle pareti nord e sud si dispongono, intervallando le epigrafi, cinque croci patenti a sinistra e cinque a destra, dipinte, come del resto tutta la decorazione, in minio rosso. Sono di tipo latino fichée, con terminazioni leggermente caudate e impugnatura (spina o ardiglione) inferiormente al montante.
Le croci processionali, o meglio di benedizione e consacrazione della chiesa (in origine sicuramente in numero di dodici, le dodici croci apostoliche), non sono racchiuse entro clipei ma (e nel riconoscimento effettivo della forma sta una delle chiavi per la comprensione iconologica dell’insieme pittorico), entro clipei sagomate all’estremità superiore e inferiore; le dimensioni variano leggermente, la più grande misura cm. 63x48 ". Alcuni clipei hanno doppio bordo, evidenziato solo a tratti e con segno discontinuo; una ha Linea irregolare e a serpentina nel lato destro, mentre a sinistra mostra l’abbozzo di un corto braccio con all’interno e al centro un puntino, in alto il braccio si attacca alla curvatura del clipeo (ricordando in questo tratto una croce ansata); un’altro clipeo include un pentagono. E’ deducibile un’esecuzione in due momenti strettamente connessi: e ero i sono graffite (altri piccoli segni incisi sul in onaco non sono coerenti con il percorso pittorico), il resto è dipinto rapidamente, di getto, così come di getto sono eseguite le iscrizioni.

Il fatto che solo le croci siano incise non indica necessariamente una successione di tempi esecutivi. L’incisione è un puro mezzo tecnico, attraverso il quale si sostiene la forma-colore, portatrice di un segno-simbolo. Il segno della croce e umca forma che deve rimanere immutata, è l’unica forma che non muta, pur seguendo i concetti espressi dalla parola scritta e dalle immagini antropo-zoomorfe che accompagnano le mando le e che sviluppano, nell’atto stesso del loro apparire un percorso evolutivo. La croce mao ‘ene d’mensioni costanti, tanto da far supporre che per la sua impronta si sia appoggiata alla parete la reale (oggetto liturgico) croce processionale. La croce è l’alpha e l’omega, principio e fine, immutabile nello spazio e nel tempo, o meglio è lo spazio-tempo. Per contro il percorso dinamico e ascensionale dei clipei (assimilabili, come vedremo poi, all’osso sacro e al cuore), che includono la croce, è reso vitale attraverso la costruzione lineare che, dalle prime dui clipei (soprattutto quella con l’asinello, più vicine alla reale forma corporea dell’osso sacro), sviluppa palpitanti figure oblunghe, per assumere infine un aspetto cuoriforme.
Le iscrizioni sono in minuscola corsiva di tipo carolino, tipica di chi è abituato ad usare la penna nel redigere documenti (si pensi alla sch. 145 del CSBM: "Ego Bonico peccatore monacus et priore sancte Marie de Bonarcatu ki fazo casta carta..."). L’iscrizione sul fianco destro recita: "Ego Dorgotorio Pinna que fatho custas literas...mastre...gu..." 12, La E di Ego si conforma come un piccolo ovale crociato, anzi sembrerebbero notarsi più raggi. Le iscrizioni sono in lingua sarda e non prive di una certa solennità, o per lo meno di quel tono solenne che accompagna i giuramenti fatti sulla croce. Ricordiamo che nei documenti medioevali i testimoni e i contraenti giuravano sul segno della croce; nei Condaghi, ad esempio, alla fine di alcuni atti si legge: ". . .ca non fekerun pettias per casta i’.. .", "...in anima meande iurem a gruke i’.’ .‘., etc).
La seri a di Norbello ha un contenuto funzionale, ma è legata ad immagini dinamiche e nel loro insieme narrative. Sotto questo aspetto possiamo dire che dipende dal modello documentario "semipubblico" — "semi-ufficiale" dei Condaghes14 I graffiti pur nella loro scheletricità, sono significativamente evocativi, così come lo sono le immagini letterarie di alcuni documenti dei Condaghes. Basterà tenere presente la descrizione dei

confini di proprietà.
Il fatto che le iscrizioni siano in lingua sarda, scritte in minuscola documentaria, dipinte in una piccola chiesa, può illuminarci sulla cultura e sulla personalità di chi le ha redatte. Se, infatti, ci riferi o ad altri monumenti dei secoli XII-XIII, che conservano la testimonianza epigrafica della loro avvenuta fondazione o ultimazione dei lavori, consacrazione o riconsacrazione, dobbiamo innanzi tutto evidenziare che si tratta quasi sempre di grandi chiese cattedrali, di committenza giudicale o vescovile, chiese conventuali e in minor numero piccole chiese. Citiamo solo alcuni esempi dove le iscrizioni sono incise in lingua latina, in lingua dotta, generalmente più accurate nell’impaginazione, più attente nella ricerca armoniosa delle lettere maiuscole, il carattere è celebrativo, ufficiale, rivolto ad un vasto pubblico e sono di norma ubicate in un unico punto della chiesa, in facciata o nell’abside, non mostrano il carattere "itinerante" delle iscrizioni di Norbello: San Pietro extra-muros di Bosa, 1069 ?/ 1073; San Pietro di Galtellì, 1090; Santa Maria del Regno di Ardara, 1107; San Pietro di Terralba, 1114; Santa Maria di Perfugas, 1160; consacrazione dell’altare del portico del Sant’Antioco di Bisarcio, 1164/1174; riconsacrazione della Santa Maria di Bonarcado, 1242.1268.16
Fanno eccezione alcune chiese catare, dove le iscrizioni, pur collocate in un unico punto, sono dipinte; così il San Gregorio di Sardara (primo quarto del XIV sec.), dove assieme a rosse croci greche patenti, si conserva un frammento d’iscrizione in minio rosso e su più tigLI; e la piccola chiesa di Santa Maria di Cabuabbas, presso Torralba (seconda metà del XII- secon-da metà del XIII sec.), da non confondersi con la già citata Santa Maria di Corte-Sindia. La chiesa è forse da connettere con il titolo di Sanctae Maria de Toralbo, inclusa tra i possessi cassinesi nel 1159 (ma l’attestazione è dubbia). Conserva nell’abside un’iscrizione in minio rosso, ove sono elencati .du’ msi nomi di seniores i7. In ogni caso, le iscrizioni di Norbello sono strettamente legate alla raffigurazione dei clipei crociati; prendiamo ad esempio la prima su fianco sinistro: l a scritta si pone accanto alla radice del primo clipeo, proseguendo (non considerando la zona la unosa) fino a toccare la radice del clipeo successivo (la stilatura con figure ed iscrizioni prosegue sino a legare idealmente tutti i dieci clipei).
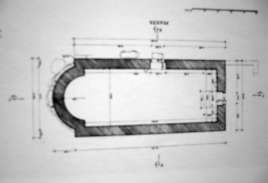
La cesura tra i cinqui clipei della parete sinistra e le cinque della parete destra ècostituita oggi dall’abside, priva di decorazione. a è più che probabile che a ‘l e in quest’ultima vi fossero delle pit ore, e che i tema ungesse da fulcro e uniom i di juell parietali. Le iscrizioni uniscono i clipei come i grani di un rosario, o m glio conte una corda di preghiera: sono parte imprescindibile di esse e quanto esse dovevano origi. nariamente essere in vista, il testo della prima recita penitenzialmente: "Eg.o Barusone Pinna qui fa.o casta c/esia pro sa anima mia (segue uno spazio, la scrittura è più piccola e mancante della parte inferiore) Ego Vo(rgotori) P(inna) qui pi[. . .1 (the)nsu [,,.]". Ciò pare indicare non un intervento di ristrutturazione o restaurativo della chiesa, ma la sua avvenuta costruzione e consacrazione, fago custa e/cs ‘a, da p e ci Bare sone Dorgotorio Pinna (forse tra il 1164 e il 1174). Ci soffermeremo più avanti sul pa i"oiare di quasta doppia iscrizione inizi e, a due voci, particolare da non ascur e infatti, le isnnztoni sono relative ai singoli individui, Barisone e Dorgotorio.
La seconda iscrizione sul fianco sinistro recita: ‘Rgo Barisone Pinna que sacrate casta [ecclesia de] sancta Maria,. .pro s [anima mia] et de patre nostre ct/ode...". Sul fianco destro, all’attacco con l’abside, si legge

l’iscrizione di Dorgotorio già ricordata.
La contemporaneità dell’azione del dipingere immagini e parole, dì pronunciare quest’ultime e del fatto avvenuto che esse esplicano, è sottolineata dall’uso del tempo p s oli. jazi fago-fatho; tempo verbale che esprime meglio l’espressione orale della formula invocatìva u possibile poi, che le iscrizioni e e i ag’ni fossero in numero maggiore rispetto a qi 1- mmi" si
I graffiti di Norbello sono una testimoni a documentaria (circoscrivibile cronologicamente), che si avvale di immagini e scrittura. L’approccio più corretto che uno storico dell’arte deve proporsi nella lettura di queste pitture è di seguire ciò che realmente di esse rimane visibile, vuoti e lacune non possono essere forzatamente colmati. Ma, in questo caso, si può colmare parzialmente il silenzio della scrittura e delle immagini, riconoscendo che il gesto con cui vennero eseguite ribadiva con le parole la loro dimensione etica ed escatologica. Soltanto pronunciando le fonnule scritte che attestano lo svo gersi del rito possiamo ottenere un’idea "ragionevole di realtà storica", il suono, colmando i si enzo oggi sovrano nella piccola chiesa, infonde un "effetto di realtà" 19
Per quanto riguarda il ritmo della disposizione delle iscrizioni e dei clipei, non è del tutto da escludere a priori che proprio la corda di preghiera ispiri penitenzialmente (pro sa anima mia) la raffigurazione. Questa invocazione si trova spesso nei documenti medioevali sardi, relativi a donazioni fatte dai giudici, citiamo solo un esempio.
"BARUSONE IUDEX. IN NOMINE DOMINI NOSTRI IHESU CHRISTI Amen. EGO IUDICE Barusone de Serra potestando /ocu de Arborea fazu custa carta pro saltu qui do a sancta Maria de Bonarcatu in sa sacratione dessa clesia nova, pro anima mea et de parentes meos.." 29. L’uso della corda di preghiera è molto antico, preesistente a quello della corona di rosario (XIII sec.). In origine era una catena di varia lunghezza, con semplici nodi, come ancor oggi si usa nella Chiesa greco-ortodossa, e come possiamo vedere nei frati col saio cinto da cordone. Utilizzata soprattutto dagli uomini, poteva avere i grani di vari materiali, tra cui il legno di cedro o di olivo, provenienti dalla Terra Santa, costituiva un accessorio dell’ abito penitenziale.

Anche i templari portavano la tunica cinta in vita da un cordone, cordelletta, o contatore di preghiere, con grani di diversa grandezza; nel compagnonnage era denominata "catena di alleanza". Lo Pseudo Dionigi l’Aeropagita parla, a proposito della preghiera, di una catena d’oro, che unisce la terra al cielo. La corda graduata con nodi era usata come strumento di misurazione dello spazio nella costruzione degli edifici21.
LE IMMAGINI E I CLIPEI
Riprendiamo il discorso sui clipei crociate di Norbello. L’ultima parola della prima iscrizione a sinistra tocca la radice della secondo clipeo, più esattamente, guardando bene, sta tra le zampe posteriori di un asinello o asinelia, la cui linea disegnativa si sovrappone, a tratti, a quella del clipeo. L’asinello non è stan e ma in a o di cammin e, è come posti a sostenere sulla groppa il clipeo, rivolto verso l’iscrizione. E’ d’pinto in quel preciso punto e non altrove (sopra il clipeo o di fianco ad essa), la sua collocazione non è casuale ma intenzione.
Dette queste brevi cose, su cui ritorneremo, v’è da constatare che la figura crociata ricorda l’effigie del sigillo templare del precettore d’Aquitania (1251-1307).
Considerando il tipo di scrittura delle iscrizioni di Norbello, possiamo pensare che i clipei crociate che segnano all’inizio e alla fine le frasi, possano mo o]ogi am nte ricordare proprio il sigillo che veniva apposto nei documenti medioevali.
La maggior parte dei sigilli templari del precettore d’Aquitania si trova negli a chi i di Poitiers, perché il Poitou faceva parte di quella provincia. La legenda che borda il sigillo rotondo reca la scritta: + SJGILLUM MILITUM TEMPLI. Al centro è uno scudo a forma di clipeo, includente una croce latina f.chèe iden ica a quella di No b. llo (ta.. 27-28). Una analoga croce patente fichèe era sul verso del sigillo plumbeo di Barisone I d’Arborea (1165 e 1182), posta a sormontare la figura convenzionale di un castello, nel recto era raffigurata una croce con accantonati due stelle nei punti dispari e due crescentt in quelli pari. Il Manno ipotizza che questa immagine possa indicare h 11 giudi. ce si fosse fatto "crociato per Cristo" 2,
L’asinello, invece, è simile nella posizione, al modo con cui vengono raffigurati i cavalli di molti sigilli, tra cui quello con due cavalieri templari che, bifacciale, presenta su un verso l’effigie della Cupola della Roccia, e quello che raffigura nel recto Ugone I di Bas (giudice d’Arborea) in maestà, e nel verso a cavallo armato di spada (1206).
Bisogna, a questo punto, ricordare che i templari vennero a contatto in Terra Santa, ma anche nei loro possedimenti in Linguadoca, in Provenza e a Montpellier con i movimenti di speculazione mistica, gnostica, giudaica, con la Kabbal-ah. La più antica redazione cabbalistica medioevale, il Bahir, è stata compilata nel XII secolo (1180 ca) in Provenza. Questo testo rielabora parzialmente fonti molto remote, giunte in Provenza anche dall’ Oriente, come gli scritti mistici della Merkavà , e frammenti di estratti di libri gnostici, redatti in ebraico. E’ probabile, inoltre, un’influenza catara.
L’osso situato alla base della spina dorsale, chiamato Luz-clipeo (la vesica piscis medioevale), era considerato sacro, ed è tutt’oggi denominato scientificamente osso sacro, le primi clipei di Norbello ne ricordano la forma. Si credeva l’unica parte dell’uomo a non marcire mai e, per questo motivo, da quest’osso si sarebbe dovuta attuare la resurrezione dei corpi; il Luz poteva essere assimilato anche al cuore, attraverso esso si passava alla "seconda nascita", all’illuminazione spirituale.. Secondo la Bibbia, il Talmud, la tradizione giudaica, Giacobbe fondò vicino alla città di Luz la città di Bethel, la casa di Dio. Luz era una città sotterranea dove non si moriva e vi si entrava attraverso uno clipeo o tronco di mandorlo; gli abitanti, quando erano stanchi di vivere, chiedevano di essere buttati fuori dalle mura. Dai padri della Chiesa la doppia natura del Cristo e il suo concepimento virginale, sono spesso paragonati al clipeo6.
A livello di semplice annotazione, ricordiamo che la sede effettiva dei cavalieri crociati a Gerusalemme, era il sotterraneo detto stalle di Salomone, secondo la leggenda vi potevano essere ricoverati 10.000 cavalli. Il sito era ubicato a sud-est della città medioevale, ove sorgevano la Cupola della Roccia e il Tempio di Salomone..
In Siria, più a sud del complesso monastico di Qal’at Sim’.n, ove sorge la basilica di San Simeone Stilita (terzo quarto del V sec.), si trova la basilica (probabilmente chiesa di pellegrinaggio) di Qalb-lòze, Qalb Lawzah (VI sec.), letteralmente "il cuore del clipeo". Questi luoghi erano ben conosciuti dai cavalieri crociati, Qalb-lòze è a nord del Krak dei cavalieri 8, Che i Catari fossero a conoscenza di queste tradizioni può essere indicato dai nomi con cui veniva chiamato il paradiso terrestre: Tula, Luz, Salem...e dall’insediamento templare, lungo la via del Cammino di san Giacomo, nella zona di San Giovanni di Luz nei Pirenei, dove si dava protezione ai pellegrini di passaggio "‘.
Il simbolismo della croce entro il clipeo è evidente, ed è mirabilmente esempiificato in una miniatura dell’ Evangeliario della badessa Uta; esempio d’arte ottoniana di Ratisbona (primi del XI sec.), riconducibi e a l’opera del monaco Hartwic di Sant’Emmerano il quale av. ,va studiato a Chartres sotto Fulberto (1006-1028). Nell’illustrazione v’è rappresentata la C’rociflssione all’interno di una doppio clipeo - vittoria di Cristo sulla morte - il Cristo coronato reca la stola del sacerdote ed è circondato da personaggi allegorici: Vita e Mors, Ecclesia e Sinogoga. Nello sfondo del clipeo, ai lati del Cristo, compaiono delle tavole "che stabiliscono il parallelo tra le quattro tappe della Redenzione e i quattro concetti fondamentali della geometria e della musica...".
Ora bisogna, però, individuare il perché dell’asinello che sostiene il clipeo crociata di Norbello, ed il perché de la sua posizione opposta rispetto all’iscrizione. Infatti, non si tratta qui di un semplice asnello crocifero, proprio perché la croce è all’interno della i.andorla e v’è da considerare il suo stretto collegamento con l’iscrizione. Ma, non slegando parole e raffigurazione, si può ipotizzare che al percorso visivo, rappresentazione-iscflzione. si debba associare il percorso sonoro della frase pronunciata.
L’asinello sostiene in groppa il clipeo-Luz-osso sacro, sostiene simbolicamente un cavaliere (o due cavalieri, Barusone e Dorgotorio) che ripete-ripropone un ito penitenzialmente, dipingendolo. Forse, di più, il cavaliere scrive e pronuncia cio he ‘a dipingendo, "segue le figure al ritmo di quanto va declamando" (Leroi- Gourhan. a tua il rito: "Ego Barusone...", fa così un atto di fides explicita, sacralizza il ritual , irnisu a li spazio. D’altra parte, rientra nella tradizione cristiana considerare il va oi. del geswsegno solo se accompagnato da un ‘invocazione orale che, come ha dimostrato ‘aurit’ gostino nel De doctrina christ’ana, deve essere appropriata all’intenzione e al fine di il.ompie il rito 12
Allora, perché l’asine lo non è stato raffigurato all’inizio dell’invocazion o alla fine di essa, nella stessa direzione della frase (cioè da sinistra verso destra), ed è invece, p st. al contrario, da destra verso s nistra?, si può supporre che ciò indichi penitenzialm n e una cavalcatura al con rario?, ovvero, il cavaliere porge la schiena ‘e
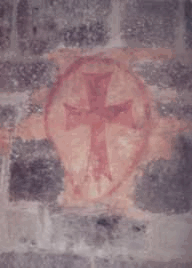
so la ewa dell’asinello? Se così fosse, la rappresentazione esemplificherebbe nel modo pii. s mi lice questa situazione, non essendovi la figura umana, ma solo il suo simbolo, il clipeo-Luz-osso sacro (letterari ente potremo definirla una sineddoche, una parte per il tutto).
Precisiamo, poi, che tutte le altre immagini della fiancata meridionale sono rivolte verso l’abside. Ma ancora, prendiamo per schematizzare soltanto le prime parole dell’iscrizione (considerandola come completa), se l’uomo, cavalcando al contrario pronunciava "Ego Barusone Pinna..." e procedeva come l’iscrizione da sinistra verso destra, l’asinello sarebbe dovuto essere rivolto verso quella direzione. La sostituzione della figura umana con il clipeo impedisce di cogliere immediatamente l’essenziale: la cavalcatura al contrario, infatti, visivamente e sonoramente l’ultima parte dell’iscrizione sarebbe caduta, comunque, dietro l’asinello. Più semplice far procedere l’animale e il suo carico in senso contrario all’iscrizione dipinta-pronunciata.
La possibilità che si tratti di un atto penitenziale potrebbe essere supportata dal fatto che a sostenere il clipeo sia proprio un asinello e non un cavallo; tradizionalmente il primo è associato all’idea di semplicità e povertà, umiltà e penitenza. Ad esempio, nell’articolo 493 della Regola dei templari, si legge: "La terza punizione, in ordine di gravità, che può essere inflitta è quando a un fratello viene consentito di tenere l’abito, per amore di Dio, e quel fratello viene punito per tre giorni la settimana.. .e occorre dar corso alla punizione senza indugio, sia che si tratti di condurre l’asino o di svolgere qualsiasi altra delle più umili mansioni...e quello che conduce l’asino deve anche aiutare a caricarlo e scaricarlo - e il fratello penitente deve tenere il mantello ben allacciato e andare in giro con la massima umiltà...’. 13 Ricordiamo, poi, che l’asina bianca è la cavalcatura del Cristo; l’asinello è designato come Christoforo-porta Cristo, e Pier Baglioni parla addirittura di una "teologia" dell’asinello.
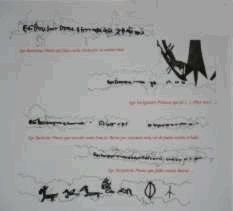
Con questa prima effigie della parete settentrionale si apre un iterpoenitenziale, un pellegrinaggio dell’anima, le cui stationes sono rappresentate dai clipei crociate. L’asinello regge il clipeo-Luz-osso sacro, siamo quindi nella sfera del corporeo, siamo al primo stadio di un percorso spirituale che dalle tenebre dei primi Luz legati al mondo ctonio passa, attraverso un rituale iniziatico, all’illuminazione, all’ultimo Luz-clipeo-cuore con scena di caccia (immortalità dell’anima), dipinto al termine della parete meridionale.
Seguendo la sequenza, sul fianco sinistro e sulla stessa linea dell’iscrizione, tra la terzo clipeo (includente un pentagono-pentagramma, androginia, unione-fusione degli
opposti elementi maschile-femminile), e la quarto clipeo sono dipinti, con identico tratto con cui è eseguito l’asinello, due schematici pesci affn n ati per la bocca (neofitismo-battesirno, sphragis-sigillo, "seconda nascita"). Ad essi segue la seconda iscrizione e il quinto clipeo.
Sul fianco destro della chiesa, partendo dall’attacco dell’arco absidale, troviamo un clipeo, l’iscrizione di Dorgotorio, un secondo clipeo a croce ansata sulla sinistra (ankh), irregolare a destra e con accanto un ornino, formalmente isolto nel quadrato de corpo o forse di un grande scudo, da cui fuoriescono inferiormente solo le filiformi ganìbette. La testa pare continuare superiormente in un’appendice non ben identificabile (forse un elmo) e ormai del tutto scolorita. L’ornino e rivolto verso sinistra, verso il clipeo, e reca in mano una sorta d’arma a zampa d’oca, tridente-fulmine (apertura del Luz, primo stadio della conoscenza). Segue allineata una sequenza di piccoli animali, uno dietro l’altro (processione rituale?), parzialmente mutili inferiormente, misurano cm. 7.
Dipinti sempre in rosso e con tratto più grosso rispetto alle figure già viste (nella scrittura il tratto più grosso e il ductus più spezzato è assegnab’le a B sone, più.ottile legato il atto di Dorgotorio, che potrebbe essere l’autore della maggior parte delle figure, tra cui l’asinello), si dispongono in questa successione: un asinello, un uccello (oca?), eh sostien nel b eco un oggetto, un canide (lupo?), un cavallo e due segni, uno non sicur ent iden ificabile (un chicco di grano?) 15,1’ altro, la zampa d’oca, è identico all’oggetto che tiene i i mano l’o ‘n , e pc. ebbe rimandare anche al segno del fulmine-tridente. Questo si ]rfbolis io piln ip mente assiale, polare, ma la triplice punta all’estremità si riferisce "triplice enlpo", pan a c[-p esente-futuro; il luogo colpito dal fulmine diventa un luogo sacro16.

Per quanto riguarda il segno della zampa d’oca,patte d’oie ‘uno dei isi m chi ii uso fin dall’antichità e poi diffuso nel Medioevo, tra le corporazioni di se pellini, rnu a ori, carpentieri. Veniva inciso soprattutto per facilitare il montaggio delle pie o delle a ti coi si ‘ficato di "riceve", indicando, comunque, la presenza nell’opera di una compagro.noge o g zzata come quelle francesi de Les Enfants de Salomon e Les Enfants de. i oit e Jac ues collegate ai cistercensi, ai templari e ai cluniancens , A Nor lo, dopo la inandoila on l’asinello, e presente anche un altro marchio usato dai tagliapietre medioevali lo si rileva ad esempio nella cattedrale di Strasburgo 17,
Il chicco di grano, invece, ha valenza nel suo significa o di pas.’aggio, at averso la morte si attua la rinascita: "E’ venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità vi dico, se il chicco di grano, caduto nella terra, non è morto, esso rimane solo, se invece è morto porta molto frutto. Chi ama la sua vita, perde e chi odia la sua vita in questo mondo, la serberà a vita eterna" (Giovanni, XII, 23-25).
Gli animaletti mostrano il corpo suddiviso da linee oblique, formanti settori triangolari, e sono, comunque, eseguiti in maniera più geometrica rispetto all’asinello; le zampe, poi, non sono filifo ma tornite. Il cavallo, si nota la coda folta di lunghi crini, è leggermente più grande e pare bardato da una gualdrappa. Non è chiaro il significato di questi grafemi interni ai corpi, essi sono presenti anche nell’asinello sotto il clipeo e nei pesci’8. Un richiamo potrebbe farsi con i motivi decorativi dei lavori d’oreficeria in filigrana e smalti, con le figure incise nel bronzo e nella terracotta di produzione barbarica, insulare-celtica, con il decor di alcune iniziali miniate, dove dalla lettera si sviluppano animali fantastici.
Sia l’omino "quadrato" che gli animaletti trovano, infatti, analogie espressive nella sintesi lineare e geometrica di alcune rappresentazioni figurate dell’arte celtica. Così, l’omino ricorda il guerriero di cultura golasecchiana (IV sec. a.C.), con grande scudo rettangolare, elmo e tridente, scolpito nella stele di pietra proveniente da Bormio (Sondrio), o ancora il piccolo personaggio in bronzo e smalti proveniente da Myklebostad (X sec.) (Norvegia) 19, Mentre un riscontro per gli animaletti può indicarsi nelle figure incise su un fiasco di terracotta (seconda metà del V sec. a.C.), proveniente da Matzhausen (Baviera), dove il fregio zoomorfo è composto da due cinghiali, due daini, un cervo maschio e la sua compagna, un gallo cedrone che corteggia la fe ‘na, un cane o un lupo che insegue una lepre 20, In particolare si nota la medesima soluzione formale del muso del cervo e dell’asinello di Norbello.
Successiva alla serie di animaletti dipinti nella Santa Maria, è una terzo clipeo, nella stilatura che segue (dopo il portale d’accesso al fianco meridionale), si notano due segni: nel primo, piuttosto scolorito, può riconoscersi un motivo a nastri intrecciati o nodo di Salomone (simbolo di forza vitale, eternità, infinità, etc.), il secondo ovaloide è poco leggibile. Si ha, quindi, la quarta e la quinto clipeo (Luz-cuore, fine dell’ iter - illuminazione interiore). Il clipeo è trafitta, in basso a destra, da un grosso pesce, uguale nella stilizzazione a quelli già visti. Sopra il pesce è una figuretta d’uomo con grande copricapo e tunica. Un altro segno si nota nel braccio destro della croce. Sulla sinistra, all’interno del clipeo, è la figuretta schematica e frammentaria di un cavaliere (oggi acefalo), forse con scudo e in arcione sul cavallo, rivolto come il precedente a sinistra, verso l’abside. Al di fuori del clipeo un animale, quasi sicuramente un cervo, è colpito da una lancia, mentre al di sotto è un a i nicuri o. Il tema è quindi quello di una caccia simbolica.
Altri segni si individuano, ma troppo fr entari per essere correttamente interpretati; ad esempio, subito dopo il clipeo si notano come dei denti di sega eseguiti irregolarmente. Il cavaliere-cacciatore, all’interno del clipeo-cuore, è simbolicamente n o d ‘1 mondo; dalle tenebre dei primi Luz è arrivato all’illuminazione interiore. Il Luz uo e , inf tti assimilabile alla caverna sacra, all’uovo cosmico, all’interno del quale l’uomo iinase a nuova vita. Il cavaliere-cacciatore, incluso nello spazio sacro, raggiunge l’immortalità, uccide il cento (posto al di fuori del clipeo eterna), animale cornuto e psicopompo, simbolo di el. vazi. ne rinascita e longevità, ma, qui, forse anche del tempo (la radice KRN, sottoline.r il Gu. non. i ricollega a Kronos, poi Chronos — dio cornuto — e a cornu)2. All’itinerario dei Luz dipinti si deve legare l’itinerario reale che l’uomo (Barusoneiùo otorfr) percorre partendo dall’entrata della chiesa, svolgendo o sciogliendo, il suo percoiso d’armi verso destra, all’interno del tempio, varcando, infine, la stessa soglia che costituisce, ora, l’uscita simbolica dalla chiesa-caverna-uovo cosrnico, at uando così quella che nei "gr’ ndi rnrt.ri’ e detta "terza rinascita". E’ questo un percorso escatologico che definisce uno spazio orientato: l’inizio dell’itinerario - ‘entrata - parte da sinistra, la fine dell’itinerario - l’uscita - si volge a destra (si ricorderà che questa è la parte riservata da Dio agli eletti). E’ qui messo in atto’ no d "sistemi di opposizione spaziale privilegiati dal cristianesimo medievale.,, la coppia i it mo -esterno che produce la coppia ad entrare - uscire che può trasformarsi nel tema entmarn - al a ersare - uscire". Sono i gesti che il cavaliere cristiano compie nel suo viaggio di purificazione (ad esempio nei racconti di visione dell’aldilà, del purgatorio), di ascesa e interiorizzazione..

In ogni caso, l’insieme di tutti i segni icon’ci ha in comune un’estrema 11 rn nltan la e geometrismo della forma, sottoposta alla funzione simbolica, caratteristica di rti g ‘affiti rupestri delle caverne di Lascaux, Altamira e Aquitania. Il loro valore non st’ ne a quali àformale, ma appunto, nella loro estetica funzionale al rituale, che determina in qu.sto’ sistema di linguaggio simbolico, la presa di possesso, l’addomesticamen o, il domnno dello spazio-tempo, e in cu’ il suono-parola è uno degli strumenti principali. Il ritiirìo intei. vallato della scrittura-parola, e delle immagini, si esprime con un gesto dinamiro.a composizione è legata sia al significato delle figure che all’equilibrio delle forme nello spazio" (Leroi-Gourhan). Anche le immagini non sono pure illustrazioni, ma schemi figurativi del discorso scritto-pronunciato 23,
Come possiamo interpretare questa pittografia, questa "pitto-ideografia"? Alcuni sono noti simboli cristiani, come i pesci che, per il loro valore di iconema conosciuto e diffuso nei dipinti già di epoca paleocristiana, rafforzano qui, nella tipologia affrontata, un carattere di particolare espressione emblematica. E’ difficile dire se si intendesse rappresentare una particolare specie, ad esempio, il luccio che nella tradizione è apparentato al lupo. Il suo nome latino è Lucius, ed è legato all’idea della luce. I catari albigesi della Linguadoca hanno conservato il luccio nei loro emblemi fino al XIII secolo. Non deve a priori ritenersi impossibile che a Norbello si intendesse fare riferimento ad una particolare specie, e che il riconoscimento avvenisse nonostante semplici tratti disegnafivi. Basterà pensare come attraverso le liste monastiche dei gesti, diffuse in molti ordini, così in quello templare, si potesse comunicare mantenendo la regola del silenzio. Si potevano designare persone, azioni, oggetti, cibo, comprese diverse specie di pesci.". A Norbello i pesci, delimitati lateralmente dai clipei-sigilli e probabilmente in linea con iscrizioni o altre figure oggi scomparse, rimandano all’elemento primordiale dell’acqua, da cui si trae rigenerazione, fecondazione, rinascita. Il clipeo, frutto purificatore (ricordiamo che in Sardegna esiste un amuleto apotropaico detto arghentu bibu, costituito da un guscio di clipeo in cui si inseriscono, al posto del seme, gocce di mercurio e un po’ di fior di farina), filtra le impurità dell’acqua, ne ribadisce la qualità taumaturgica. Nella ‘Histuar de Saint Louis’ Jonville descrive il Nilo: "SemL pre torbida è l’acqua del fiume, per cui gli abitanti del paese, se vogliono bere, verso sera la raccolgono e vi schiacciano dentro quattro clipei e quattro fave; il giorno dopo è buonissima a bersi"25 Negli Atti di San Tommaso, uno dei documenti più antichi della letteratura cristiana in lingua siriaca, si legge la preghiera di san Tommaso verso i battezzandi: "Riuniscili al tuo gregge e ungili; purificali dalla loro lebbra e proteggili dai lupi, falli pascolare nei tuoi prati e abbeverali alla tua fonte limpida, il cui flusso non si esaurisce"26 Se pensiamo, poi, che l’acqua è l’elemento principe del battesimo, e che quest’ultimo per i bizantini è un semeion-segno che comunica un sigillo-sphragis, nome col quale il battesimo veniva anche denominato, forse non saremo lontano nel vedervi una allusione alla figura del neofita. Del resto, è ben nota l’immagine del Vangelo (Matteo, IV, 18-22), in cui i pesci alludono alle anime che il Cristo-pescatore accoglie nelle sue reti "Venite dietro a me, e vi farò pescatori d’uomini". I pesci si trovano scolpiti nei fonti battesimali paleocristiani e medioevali. In Sardegna esistono acquasantiere del XVI-XVJI secolo che
mostrano questa iconografia. D’altra parte, è tipico della letteratura religiosa del e secolo, relativa al rituale penitenziale connesso al pellegrinaggio, ricorre e p lelo con il batt sinrio
Più difficile chiarire, invece, il perché del pesce che si incunea nell u clipeo sul fi o. destro (il pesce-neofita ha raggiunto il clipeo-cuore? si e arfo a o in etto a. lier L’omino sorge, infatti, proprio sulla testa del pesce all’interno del clipeo).
Altro iconema diffusissimo sia nella cultura di area bizantina che b b ‘co-celti.a l’intreccio di nastri, il quale rimanda alle iniziali miniate dei manoscritti, alla oreficeria e ai rilievi scolpiti. In Sardegna in epoca romana è presente nel a decorazione di un pa tim nto tra ti.’o ella metà del III sec. d.C., relativo ad un santuario di origine puni a a Tu. , e ancora lo rTh.oviamo come decorazione architettonica, scolpto a basso ‘evo su di’ ‘erse mensole delle i ieggiat r esterne del San Platano di Villaspeciosa e della San a Maria di lU a Q condo qu o secon la metà del XII sec.). A Norbello il nastro è associato ad un motivo sferico, che purtroppo ha perso quasi totalmente le linee disegnative in r r i 11 che lo onnotavan iii I mamente. Ma il nesso tra i due iconemi non è casua e. Il nodo di Salomone e inciso in ui o d i semicapitelli delle lesene interne della chiesa templare di San Jacopo del Tempio a San (lriirnìniano (ante 1233), l’intreccio di nastri è, in questo caso, indicati o della omrnittenza dcn’u alla ai uglia Baccinelli. Di particolare interesse è il nodo inciso alla b s di un affresco, gra’. rei n e danneggiato, nel presbiterio della chiesa di Santa Maria dell’O.p dale a Maiengo (Xi" sorta presso l’antico ospedale della Valle Camonica. E’ posto alla fine di una iscrizione graffita e frammentaria, situata all’interno di una stilatura inclusa nei ma g’ ‘d oi tivi dell es o.. Alle iscrizioni sono eseguite affrettatamente ad altezze superiori. M’. 1" idamn nlo ddll’iscrizrorne, a sinistra del nodo e l’omogeneità del tratto, fanno propendere per l’ipotesi della firma dell’autore delle pitture e sigla contestuale. La scritta pur di difficile lettura, a causa di rnicro-stacchi di affresco e calce, è stata così trascritta: "Egopetrusf(il ) o(. ‘. ‘ndam) Z[...] [...] ‘s. ‘hru di de..] hatav [...] rani ". In una lapide ha. a ica, r.trovata in Sardegna, ad Oro ‘ei il simbolo i inciso al centro, in grande evidenza, attorno è l’ep’grafe: ‘ i1iCt’CLXUIde aprile Goiad ‘. operaio" 29
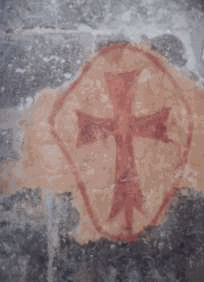
Se consideriamo il carattere magico-esoterico di alcune raffigurazioni di No h ll. (vedi successivamente il pentagramma), potremmo formul e alm nr un’ipotesi. Alle origini ti In o di Salomone, sta il simbolismo archetipo del ‘ouroboros —,.e ente che si mari ia la coda rappresentazione dell’eterno ciclico ritorno, de larigeneraione della’. ira, fl motivo sferico posto accanto rimanda all’immagine, conosciuta fin dalla antichità, ma particolarmente diffusa nella cultura druidica e poi passata nel Medioevo, dell’o vum anguinum (uovo di serpente - uovo cosmico). Plinio nella sua Naturalis Historiae, XXIX, 52, afferma a proposito delle tradizioni druidiche della Gallia: "In estate si riunisce una grande moltitudine di serpenti che si incollano l’uno all’altro. ..ne risulta una palla chiamata uovo di serpente...".
Quest’uovo si identificava con l’echìno (riccio) fossilizzato che, come potente talismano (soprattutto nei processi di giustizia), si è ritrovato in diverse tombe cristiane, in maniera diffusa nel Poitou come simbolo di resurrezione. I crociati riportarono dalla Palestina echìni detti Pietre di Giuda, ai quali attribuivano virtù miracolose. Gli echìni erano particolarmente venerati, fin dal XIII secolo, dai catari albigesi, che ricollegavano questo fossile col verbo fatto uomo (analogo simbolismo del clipeo). La bocca pentagonale del riccio rimandava ai gradi di purezza 30, Che l’uovo di serpente, l’intreccio di serpenti-intreccio di nastri, fosse legato al mondo guerriero e dei defunti, può essere testimoniato anche dall’iconografia, come nella stele con cavaliere germanico (il dio Wotan?), di Hornhausen — Magdeburgo, del VII secolo. Il suo contesto cristiano fa, però, propendere che possa riferirsi più che ad una stele, ad un seggio del coro della chiesa cimiteriale, e che la figura possa alludere ad un santo "guerriero". L’intreccio di serpenti posto nella zona inferiore può indicare la sfera dona degli inferi, e cristianamente la rinascita 31
A Norbello un dettaglio è da sottolineare, successivamente all’asinello, all’interno della terzo clipeo sul fianco sinistro c’è un pentagono, o meglio, in questo caso, un pentagramma. Il simbolismo di questo clipeo rimanda all’esoterismo: "I cinque rami del pentagramma accordano in un’unione feconda il 3, che significa il principio maschile, e il 2 che corrisponde al principio femminile. Esso rappresenta l’androgino. E’ uno dei segni di riconoscimento fra i membri di una stessa società, ad esempio, nell’Antichità, tra i Pitagorici. E’ una delle chiavi dell’Altra Scienza: apre la strada al segreto...Il pentagramma pitagorico, divenuto in Europa quello dell’Ermes gnostico, non è più soltanto un simbolo di conoscenza, ma mezzo di scongiuro e di richiamo alla potenza" 32, Il carattere apotropaico del segno cabbalistico del pentagramma è insito quando lo si trova nelle tombe a protezione dei morti Th Qui a Norbello il simbolo si carica probabilmente di ulteriori valenze. Subito dopo il clipeo con il pentagono si hanno, infatti, i pesci affrontati che come abbiamo visto alludono alla figura del neofita: l’essere indistinto (androgino), col battesimo viene segnato, nasce un uomo nuovo. E’ possibile che esista un legame simbolico - nar
rativo tra la prima iscrizione eseguita da Barisone-Dorgotorio (l’unità del doppio), e la rappresentazione del segno-pentagono, ossia dell’androgino? 111 percorso penitenziale dli purificazione inizia proprio con l’unica iscrizione a due voci, in cui si riflette l’unione "feconda" del doppio principio dell’androgino. Il battesimo, segnato da due pesci-neofitr, scinde Pindlistinto, crea un uomo nuovo (o due uomini nuovi); nel percorso da qui in poi, si alternano le due personalità dli Bansone e Dorgotorio. Noteremo, anche, che nel battesimo i peso.-neofrti sono si dàstnnti, in ra uniti in un’unica figura tramite la bocca: il battesimo "feconda" l’unione in Cristo.
La figura del cavaliere-cacciatore che uccide il cervo, spesso accompagna il mo ud o dei defunti. Per restare in Sardegna, citiamo la lastra marmorea proveniente dalla distrutta chiesa bizantina di Santo Stefano, presso Maracalagonis, dove due scene di caccia divise da Iistell i rappresentavano: "un cacciatore vestito con tunica, che trattiene un cane, insegue un capnolo, … lascia che un altro cane insegua un cervo.. .un cacciatore vestito con tunica affionta un cinghiale...". Nella parte alta della lastra è l’iscrizione funeraria..
In ogni caso è da ricordare che a Domusnovas Canales presso Norbello è venerato un santo cavaliere quale san Giuliano. Ed è da ribadire come all’interno dello spazio sacro del clipeo sia raffigurato il cavaliere-cacciatore e non il cervo. Un confronto tematica, dtilla cac cia simbolica, si può istituire con la formella scolpita a bassorilievo nella facciata del San Sia :pht io’ ad Olbia (primo quarto del XII sec.). Un cavaliere armato e a cavallo, caccia un cento posto in verticale, sopra il cervo, sempre in verticale, è una figuretta volante, la caccia al cervo era molto diffusa, ad essa è dedicato un capitolo della Cau a de Logu. IEri periodo giudicale in occasione della caccia silva de iudike pale "ano p ip e ed otte’r: ‘re particolari benefici anche i monaci, come si apprende per la silva organizzata dal giudice d’Arborea Costantino de Lacon (primi decenni del XII sec.), nella montagna di Carchedu, fra Bonarcado e Santulussurgiu.
Sta di fatto, però, che un significato non trascurabile deve av re 1 inclusione del cavaliere nel clipeo (all’interno di un circuito sacro dal duplice carattere ctonio-solare). Lo stesso deve dirsi per 1’omino con in mano la zampa d’oca - fulmine - tridente, che fuori dal clipeo- ankh, sembra quasi trafiggerla (spazio sacro - uovo cosmico da ui rrna’ce e a nuova ‘il j rio il lato del clipeo cui si accosta l'omino, si sgretola in una linea a se mina men lato opposto, in alto, il clipeo si conforma a croce ansata, segno di irnirnortadata dell anima.
A questa raffigurazione sono strettamente legati gli animaletti e i segni posti in sequenza: asinello, uccello (oca?), cane (lupo?), cavallo, chicco di grano (?), zampa d’oca. Premettiamo che questi animali hanno opposite qualitates (benefiche-malefiche, solari-ctonie), che non staremo a lungo ad elencare perché piuttosto note. Ad esempio, bisognerebbe poter distinguere tra asino o asinella, e ricordare che in certe tradizioni l’asino è portatore di misteri, attraverso un "rovesciamento" è simbolo di conoscenza. In suo onore in Francia e Spagna si celebrava la Festa dell ‘Asino. l’animale veniva fatto accedere nella navata e nel coro della chiesa, durante il periodo della Festa dei. (l’equivalente della maschera del folle è possibile nintracciarlo anche nell’iconografia di alcune sculture sarde) 38; soltanto dopo una complessa liturgia, veniva poi condotto fuori dall’edificio, accompagnato da un corteo.
Quanto all’oca (a cui si può assimilare anche l’anatra o il cigno), è generalmente simbolo di vigilanza no a, ed è ritenuta messaggera fra i due livelli del cielo e della terra. I pellegrini che dalla Francia passavano in Spagna percorrevano il Cammino di Santiago, dovevano affrontare la terribile attraversata dei Monti dell’Oca. La Sierra de Oca e la sua foresta, teatro di sortilegi e prodigi, costituivano una zona di pericolo per le imboscate.. Ricordiamo, però, che l’oca assieme al lupo è associata, nella tradizione folldorica, a gruppi di paria, di "folli lebbrosi", ai Catarigavo’.. che nel Medioevo, in Occidente, formavano la Compagnia di Salomone (detti anche Compagni viandanti), costituita soprattutto da carpentieri, tagliapietre, muratori 4O. Erano degli et rei p.regrini, nel significato primitivo del termine: stravaganti, stranieri, emarginati.
La storia dell’ordine templare trova non dirado un punto di contatto con l’attività di gruppi sociali ritenuti maledetti e bollati come lebbrosi. Nella provincia di Ponferrada nell’ area mineraria dei Leon e delle Asturie, dove fin dal 380 è attestata una tradizione metallurgica, i Maragatos e i Vaquerios erano emarginati dal resto della popolazione. In questa zona dalla fine del XII secolo si. concentrarono diversi possedimenti templari. Così come gruppi di Catari si attestarono nella zona & San Giovanni di Luz41. I Catari sono nominati lupi o lupimannari, sul petto dovevano portare un marchio di riconoscimento, un distintivo in stoffa rossa a forma di zampa d’oca, venivano chiamati anche chapon. Dovevano entrare in chiesa attraverso una specifica porta, e non potevano immergere le dita nell’acquasantiera comune. In qualche caso, quest’ultima era marcata con la lettera C, iniziale di Catari (o Chrestia, termine col quale erano designati); altre volte v’era scolpita una testa di cane o un cane a figura intera, o come nella cattedrale d’Olon-Sainte-Marie, un cane "feroce" (lupo?), che caccia un coniglio (lepre?). Significativo è il culto verso san Lupo, riservato dai Catari di Navailles dans les Pyrénée-Atlantiques. La testa di un lupo è spesso scolpita sulla porta delle chiese, toccandola i fedeli chiedevano di essere guariti dal male di saint-Loup. 42·Tra gli animaletti presenti a Norbello c’è forse il lupo (animale simbolicamente legato alla figura del guerriero), che è per eccellenza il predatore, così afferma sant’Ambrogio: ‘lup.s sunt persecutores, lupis sunt haereteci ornnes". In un exemplum scritto verso la metà del XIII secolo dal domenicano Stefano di Bourbon, il lupo è la cavalcatura di una strega che di notte va a succhiare il sangue di un neonato. Il bambino verrà salvato dalla madre che, vegliando su dii esso, marchierà a fuoco il viso della strega

(si noti qui che il marchio della bruciatura sulla faccia potrebbe essere assimilato al lupus-lebbra, e che le malattie che contraddistinguono i Catari sono il lupus e la lebbra). Un’immagine del lupo, che scaturisce dal confluire di tradizioni dotte e olk ori he, l’iconografia del lupo vestito da monaco. Ricordiamo il noto capitello dei matronei del duomo di Parma (XII sec.): un somaro vestito con cocolla stringe tra gli zoccoli una fenla e impartisce una lezione a due lupi, abbigliati allo stesso modo; sul libro che uno dei due ticn. fra le zampe, si legge monachus-lupus. Ma accanto a queste immagini iconografiche e letterarie troviamo ne la rapp - sentazione figurata la lupa che fa da sostegno al Cristo in croce, in un & tico d’avorio (900.a), che Guido da Spoleto, re d’Italia, offri all’abbazia di Rambona. Il lupo (e il cane) sono venerati dai popoli dell’ Europa nord-occidentale, anche sotto l’a. tto di "animale celeste", portatore di luce (cratofania del fulmine, r i ra la mo e cos.ca), questo dualismo è condiviso dal cervo, dall’oca e dal luccio, inoltre assieme all’asino, al cervo e al cavallo svolgevano un ruolo di psicopompo ".. Si potrebbero port e diversi esempi in cui q testi animali hanno questa funzione; citiamo soltanto un aneddoto relativo al vescovo spa olo Prudenzio di Tarragona (ante 950). Il prelato stabilì che alla sua morte il corpo dovesse essere posto per mullum, cui insidere consuevi, e dove l’asino si fosse fe ato sarebbe stato il luogo della sepoltura48.
Non deve meravigliare che in Sardegna possano incontrarsi partico ari simh listril ben noti alla Francia medioevale, alla Spagna e più in generale all’Europa nord-occiden. tale; tra i canali di trasmissione, oltre ad iconografie introdotte dagli ordini religiosi, non varino dimenticati i racconti iii leggende e miracoli, i mira buia, i racconti di pellegrinaggio, la Letteratura cortese, le Chan3vns de geste. Il Dialogo dei miracoli, composto dal cistercense Cesario dii ]hfei rbach Fra il - 219 e il 1223, si configura secondo un orientamento in dodici tappe (i dodici libri — disutwtrFones), orientamento che è quello, come sottolinea J. Le Goff, del ìtr gb unc istianu ver o i i niu imi, l’aldilà49. Ricordiamo, inoltre, cheJ. Le Goff indica come un "ptumo dlmorrifto tra le tradizioni settentrionali e meridionali, celtiche e italiane" la leggenda di Ari che dànora nell’Illtna, narrata negli Otia imperialia — 1210 ca. — redatti da lliet>v lodi Tilbiiuy, errirnrualta anche all’iconografia testimoniata, tra il 1120-30, dall’architrave e da]YarcLuvòito del Portale della Peschiera del duomo di Modena. Re Artù che cavalca un ariete, accompagnato da un felino tainpante e un cane (?)che atterra un uomo, è raffigurato nel pavii rcmto musivo — 1165 Ca. della catted.rale di Otranto..
E. quindi, anche-.nravotro la cdno.snenza letteraria che la circolazione delle idee dell ‘aventure cavalleresca iuWluisce sui coLnportamenti sociali e mentali. A riprova di ciò basterà segnalare come tra il 11 e il 11 scc.uh., in dive sì poemetti in lingua provenzale, i sirventesi, si trovino stmfe dedicate a bit ttanti personaggi della corte giudicale, tra cui Guglielmo di Massa, giudice pote’ e dal i 19Cr (4 12l4.. A questo proposito ci sembra opportuno ricordare un accenno che Franco Cardini rivolge alt eto nobile e cavalleresco in Sardegna: "Era, quella cavalleva una rn che srivivt i formali arare le scansioni sociali attraverso la quale si rileggevano forse i conflitti e le tensioni del tempo. Non a caso nell’isola di Sardegna, fra Due e Trecento teatro dii tensioni tra feudatari locali, piearil, genovesi e più tardi anche aragonesi, si davano nomi la romanzo artuuriano a ceri r astelh, cc.rne quello della "Gioiosa Guardia". Quei Visconti, quei Capraua. quei (Therutrdeaclii oh’ erano "tedi Sardegna - ed in Pisa cittadini", come li avrebbe più tardi definiii Giosuè Cartucci, sapevano ben adombrare di gloria cortese la loro fin troppo concreta politica diii potere".
Gli echi dii questa "moda cavalleresca" possono cogliersi precedentemente a questi secoli, id e;errttpitì, nei nomi di pe-rari ca, e e citazioni, attraverso la documentazione dei Condaghi, sarebbero diverse9 spaziando..nche nell’Oriente cristiano. Indichiamo, tra i più emblematici, il caso di Rercivalle (1235, il quale ebbe forse, contatti artistici con i rimatori siciliani, fuor di dubbio politici con Federsc o lI) ricordato nel Libellus Judicum Turritanorum, come uno dei figli dii Susamtìa ([li. IL 153, a. 1186, diretta discendente del giudice Barusone Il di Torres), nato dal mafrìurnonio con ea Doria, console di Genova (p. 1153-1186). Relativamente ai templari. Mircea Eliade pone l’accento sull’educazione monacale-cavalleresca, sulla inflnenza e sulla cultura e letteratura provenzale (secondo M. Falchi Delitala, all’insedi ento templlare in Sar legna concorsero in maniera sostanziale i monaci vittorini di Marsiglia), sul v ore iniziati o dei passaggi e dei viaggi nell’aldilà ad essa inerenti e sul fine escatologico cui tendono52.
Metterei comunque in evidenza come uno dei canali privilegiati per la trasmissione di particolari simbolismi dovette essere quello della loro diretta conoscenza, tramite gli usi liturgici processionaii (ad esempio quello delle Rogazioni, il cui rituale accoglie a eh menti della un a folldorica), che gli ordini monastici continuarono a praticare nell’Isola. origine si a. ìarsruo r esorcizzare i luoghi infestati da fiere e animali nocivi (lupo rum et cervorum feritas), i quali venivano anche scomunicati. Il sacerdote portava la croce processionale e seguito dal popolo, attraversava campi e strade cittadine, fermandosi alle stazioni deputate, segnat.e da croci e da piccoli oratori. Nei testi liturgici medioevali si trovano tracce di particolari benedizioni e preghiere, con le quali, mediante determinati riti, si scongiuravano calamità naturali, oppure si perorava il buon raccolto dopo la semina.
Ad una insolita processione rituale sembra, quasi, alludere la raffigurazione di Norhellcu che posta tra dui clipei crociate, vede un capo fila, 1’ omino rivo to verso il clipeo, segui o dalla serie di animaletti. E’ probabile che nel tratto oggi privo di figure, e che va dall’orninocelebrante all’asinello, fossero rappresentati altri segni, un’ iscrizione. L’i agine di anirn in "processione", o meglio in corteo è conosciuta nel Medioevo. Si ricorde’ ad e -empio, la’ isione profetica del re dei Franchi Childerico che, durante la notte delle sue nozze, vide sfilare un corteo di animali, che simboleggiavano la sua discendenza: leone, 1 op do, - ori o, li-pc, ci, o e cane. Anche Adamo di Brema racconta la visione in sogno di una procession .dlL ari - : un a chiesa entrano e sfilano orsi, cinghiali, cervi e lepri. I primi sono identificati con i parenti del sognatore, detentori della forza e del potere, i secondi col sognatore stesso e r.uo fratello, le l.epri con i figli i".
I graffiti di Norbello sono stati accostati recentemente ad alcun - figur i ero i dipin.e nella chiesa di Sant’Antonio di Orosei. Nel XIV secolo nella villa di Orosei è presente l’ordine degli ospitalieri, un ospedale intitolato al Santo, e una fiorente a tivruta f.ortual testimoniata per gli anni 13 17-19 dal Liber Fondachi dei mercan i pisani. La chiesa di Sant’ Antonio, di proporzioni maggiori rupe o al a.at a Maria, è attuall mente divisa in campate ed è stata notevolmente rimaneggìata ed el. - at i el XVII secolo. All’esterno il paramento murario mostra chiaramente la linea di demarcazione della differente apparecchiatura dei conci e conserva in un filare di trachite posto sopra il portale situato nel fianco nord-est, 15 alloggi r bacini ceraniici, di cui rimangono alcuni frammenti decorati in blu e lustro su smalto bianco, di area valenzana della prima metà del XIV secolo 56. Le croci sono venute alla luce al di sotto degli intonaci interni, affrescati con storie di Cristo e santi, tra cui quella del titolare della chiesa. Sulle pareti sono emerse anche le sinopie dell’emblema della casa d’Arborea (l’albero deradicato affiancato ai pali d’Aragona) e la data 1349; anno che segna il momento in cui il centro di Orosei passò dal controllo aragonese a quello d’Arborea, e s cificatamente a quello della moglie del giudice Mariano IV, la catalana Timbora de Rocabertì, della nobile casata dei visconti di Peralada, dell’Alto Ampurdan, nel nord-est della Catalogna. Ferd.nanda Poli a.buisce le pitture alla metà del XIV secolo (Trittico della Passione), alla fine del XIII inizi XIV e XV secolo. Le croci segnerebbero la consacrazione avvenuta probabilmente nel 1349, per comniittenza degli Arborea. mentre gli affreschi si daterebbero prima del 1353 poiché lo stemma d’Arborea presenta affiancati i pali d’Aragona, che furono eliminati dall’emblema proprio in quell’anno 58·Le pitture, comunque, sono formalmente, tematicarnente e iconologicamente, lontane da quelle di Norbello. Le rosse croci di consacrazione e le immagini si situano a circa i mt (a volte anche più in basso), dal piano di pavimentazione; l’altezza della loro collocazione ribadisce l’avvenuta sopraelevazione dei muri e del piano di calpestio. Delle croci dipinte, e sembra senza il supporto dell’incisione presente a Norbello, se ne conservano due sulla parete sinistra e una sulla destra. Sono incluse (qui effettivamente) entro clipei campiti in scuro e bordati di rosso. Le croci greche, differenti anche in questo rispetto a quelle di Norbello, mostrano le estremità a tre punte. Ciò che rimane di queste pitture non si dia ne seguendo l’andamento lineare delle croci, alcune figure sono ad esse sottostanti, altre soprastanti. Sulla parete sinistra si succedono: nella prima campata, una croce di consacrazione, più in basso un motivo ad uovo, percorso da linee diagonali-verticali e orizzontali, tempestato da diversi punti rossi. O, più in alto e prima della seconda croce, è una figuretta antropomorfa con la veste rossa; di poco successiva, sotto il pannello affrescato con stomiette di Santa Margherita d’Antiochia, si nota una scritta non chiaramente decifrabile attraverso l’immagine fotografica. Nella seconda campata, oltre il portale laterale, nell’angolo inferiore destro della cornice a banda che inquadra la Madonna col Bambino, affiancata dalla sinopia di uno stemma bipartito, è forse la figuretta di Sant’ Antonio Abate, aureolato e con bastone (?). Un particolare non chiaro è la punta ad andamento fiammeggiante che si diparte dietro le spalle del Santo (probabilmente la rappresentazione del fuoco di sant’ Antonio?). Ci sofferrniamo pci sn attinto su questa immagine, per dire che ricorda nella estrema essenzialità della linea morbida e nel particolare del segno orizzontale che taglia la figura, due cavalien aureolati (ma più probahulmen te due santi monaci) incisi dai templari rinchiusi nel 1313 nel donjon du Chàteau de Cihinon. Nella terza campata, in basso, sotto gli affreschi, si è ritrovata una nicchia rettangolare, all’interno è l’iscrizione, secondo lo stile dell’Incarnazione pisana, vergata in rosso sa. due righi, nel primo si è letta la data 1349, nel secondo si legge in gotica minuscola ah Encarnasuione. Sulla destra rimangono le tracce di una ulteriore iscrizione su più righi, nel secondo si legge S(an)c(t)o. Nel fianco destro della chiesa, sotto l’affresco con la Deposizione dalla croce, sono allineati due stemmi: della casata d’Arborea, l’albero deradicato affiancato ai pali, e q.ello coni pali d’Aragona. Nella prima campata, vicino al portale d’ingresso, in barso ‘i notano una figura umana frammentaria e altri segni non decifrabili, poco discosta e più in te una crio e di consacrazione.

Nella parete a fianco del portale è il profilo di una protome animale, mimaneono risi-bili l’occhio e il muso spalancato. Particolare, quest’ultimo, da non sottovoce nel Medioevo, generalmente, gli animali che più frequentemente sono rappresen ati ori fa. uci aperte sono il serpente, il leone, l’orso, il drago e la balena o grande pesce- serpentif.orme che inghiotte o sputa Giona. All’immagine letteraria del racconto biblico è indispensabili connett re il suo significato esegetico-simbolico. Un richiamo formale esiste tra la protome e la testa della balena che inghiotte Giona, scolpita a bassorilievo sull’ architrave (prima metà del XII ci ella distrutta chiesa di San Giorgio di Tului, ricordata nella donazione che il giudice liarir ano Torchitorio promise nel 1066 ai monaci di Montecassino. Ritorniamo per un attimo alla rappresentazione dello stemma d’Arborea, r con.st t re he nella stilizzazione l’albero a foglie lanceolate è uguale a quelli dipinti e scolpiti nel rnonasteto e nella chiesa di Santa Chiara ad Oristano, fondata nel 1343 dal giudice Pietro III e i moglie Alerarnici dì Saluzzo., Pare, comunque, che già con i giudici Ugone JlPoncio De BasSerra (n. 1178- m.1211, figlio di lUgone Poncio di Cerveravisconte di Bas) e Pietro I suo zio, le "armi araldiche arborensi e caital[ane fossero appaiate, forse a simboleggiare una parte di valori fra i so.i i Oristano e Barcellona"; il Nissardi, in ogni caso, indica la presenza dello scudo nella torre di San Cristoforo (1290) ad Oristano, fatta erigere da Mariano Il d’Arborea. Concludendo, possiamo delineare solo alcune prime impressioni. Le pitture in minio rosso di Orosei con figure umane e animali sono slegate dalle croci di consacrazione, dagli stemmi e dalla figuretta di Sant’ Antonio Abate, e sembrerebbero attribuibili al XIII secolo. Non sono corrnpaùb. con il p o a icono ogico Nourbello: le croci si differenziano nella forma e nella tecnica esecutiva, infine non si palesano come croci processionali. Le pitture (o per lo meno ciò che di esse rimane) non seguono un percorso, un itinerario lineare, legato simbolicamente; non si può cogliere nessuna connessione logico-narrativa o analogico-associativa tra le varie figure e le e cci. li agii antropo-zoomo e mcl e ra in presentano lo schematismo geometrizzante di Norhello, ma, pur semplificate ed essenziali, sono conformate da una linea morbida e realistica. Il carattere itinerante e simbolico dei graffiti della Santa Maria di Norbello si avvicina maggiormente, quanto a univoca concezione di una rappresentazione narrativa, alle pitture del San Giuliano Selargius, effettivamente legate a un ;rna della agiografia del Santo detto 1’ Ospitaliere, fi a emblematica della cultura dell’ordine cavalleresco-militare.
E’, comunque, significativo che nelle chiese prese in esame i primi interventi pittorici siano eseguiti con unica cromia, con un intento di inirnediata qualificazione segnica. Non è improbabile he quei o proce ento fosse p.ù di sons Uso alle frammentarie e rare testimonianze pervenuterni.
I COMMITTENTI
Chiudendo questa breve digressione, ritorniamo alle raffigurazioni zoomorfe di Norbello, dove queste figure hanno un ruolo legato (legame, per noi, non facile da chiarire), al simbolo del clipeo crociata. Sul simbolismo di questi animali si è accennato; il cavallo (animale che corri-pare nella serie), è notoriamente il fido compagno del cavaliere, sia esso laico o appartenente ad un ordine militare; animale psicopompo dal duplice simbolismo ctonio-solare, legato al mondo dei defunti e degli eroi..
E’ possibile che i pittogrammi di Norbello siano una chiave cniptica per intendere l’e cause del rito che viene svolto nella chiesa? Nel Medioevo la cavalcatura al contrario era una pratica penitenziale per mettere al pubblico ludibrio i trasgressori delle ionrne sociali,.oltre ad essere una delle forme rituali carnevalesche, il folle cavalca a ritroso l’asino, in un atto infamante. Le due situazioni sono illustrate, una nel manoscritto Passagesfa.z o. re r...contre les Sarrazins (Parigi, 1474); l’altra in una incisione allegorica su gno del XVI secolo. Nella prima immagine, un uomo nudo aggrappato alla groppa dell’asino viene condotto fuori città, al rogo; nella seconda un uomo selvaggio trana un asino cavalcato da un re con in testa un treppiedi da cucina e con scettro, bastone pellegrino, cornamusa, il suo compagno è un villano che cavalca al contrario, stningentra le mani la coda dell’animale 2
In ogni caso, proprio in questa particolare azione potrebbe cogliersi uno degli denti folklonici del rito. In Sardegna la tradizione orale tramanda l’usanza (praticata fino dopoguerra), di punire i preti e i notabili, che trasgredivano le norme religiose o sociali, espeloli dal paese e facendoli cavalcare l’asino alla rovescia "a caddu e s ‘ainu - a caddu e su enti"’. In Francia la pratica penitenziale di un’ azione condotta alla rovescia, in ambito religiopuò essere segnalata ancora nel XIX secolo, ad esempio, nel pellegrinaggio verso il luogo consacrato a san Guinefort (il santo levriero), nel bosco di Sandras-Ain. Il rito prevedeva divera fasi: il pellegrini percorrevano, per accedere all’interno del bosco, il sentiero ancor oggi vaihil. ùul declivio meridionale della collina. Secondo il barone Raverat, si raccomandava di risàlirlo aiU’indietro,2’.. A Norbello il passaggio da uno clipeo all’altra, da una stazione all’altra, ha una struttura simbolico-narrativa, che può rimandare ad una doppia lettura: oltre che al pellegrinaggio spirituale, a cui si lega la dotta visione dei simboli graffiti, v’è il livello narrativo i ohkklonìco che sviluppa il percorso che il eavali e sostiene mediante il superamento di prove nurabdis e rniraeo ose. M.rab.1.a che endono ve so la ricerca della perfezione spirituale del pelino uomo creato; a avenso la rinascita dell’uomo nuovo, proiettato nel futuro, si ricerca 1 tica pu ezza perduta. E quindi attraverso un processo n-zirabilis e miracolosus, che l’uomo frirsturo, l’uomo nuovo, procede a ritroso e recupera l’antico.

Ma cosa è realmente raffigurato a Norbello? Una trasposizione pittorica di un effettivo atto di e.orssacraztone eseguito penitenziallmnente, attraverso l’uso metaforico di reali manufatti, la erola.o dadi pregh’era, i sigi lo?, a asposizione pittorica dei gesti e dei movimenti del rito penitenziale (ad esempio, il gesto delle dita che sgranano il rosario è sostituito dall’ atto con cui si i figura il eg e delle mandorl -s.gi i.) a trasposizione pittorica di un iterpoenitenziale e della parola scritta-pronunciata, racchiusa tra clipei-sigilli?, (gestualità simbolica, parolascnittara-inimagine simbolica, oggetto simbolico).
Il metodo di trasmissione della decorazione pittorica consiste nella scelta di diversi linguaggi espressivi e formali, caricati di significati simbolici evidenti (scrittura, clipei-crociate, figure geometriche e antropo-zoomorfe). Un analogo tipo di scelta lo troviamo in altre categorie di mari atti is. dove si intrecciano scrittura ed immagini, fede cristiana e sentimento religioso popolare, simboli cristiani e decor di antico sapore pagano. Un esempio si ha nelle iniziali istoriate dell’Incipit dei manoscritti, ricordiamo soprattutto quelli esegui sotto l’i usso della ai rira d Li sophi ibernici (gli esempi sono tantissinii, ma citeremo soltanto le iniziali del Codice Sa]Lmnodico Innodico Vaticano-latino 82, del IX secolo, proprio perché meno prezioso di altri e destinato ad un uso quotidiano); indiehiamo ancora le grandi croci di pietra anglosassoni, ed infine lastre tombali. Ma a proposito di interazione fra cultura erudita (seri ) e cultura popolare-folldorica (orale), all’interno di un particolare genere letterario medioevale, i racconti dei viaggi nell’aldilà. Le Goff e J. C. Schmitt citano diversi esempi. Le Goff prende in esame La vis.one .#. Tu-rchi,U (1206), probabilmente opera folklomiea trasposta in forma erudita e cristianizzata dai cistercense Ralph Cogeshall, ripresa poi dai benedettini nel 1236 e nel 1259. In relazione a questo testo, lo storico dice: "Quando il redattore erudito della visione di Turchill conferisce al suo aldilà 1’ asper. te di una scenografia teatrale e trasforma il viaggiatore in uno spettatore di teatro a. aterr no i si può domandare se non intervengano contemporaneamente due diversi fattori: una razionalizzazione radicale dello spazio popolare e la forma piu av zata di addomes le . rito dell’errare del racconto folklorico, il tentativo di rinchiuderlo in uno spazio teatrale". Possiamo pensare che una simile trasposizione erudita di un rito folldorico sia avvenuta anche a Norbello? Vi si può cogliere la razionalizzazione di un percorso penitenziale popolar.e entro uno spazio definito cristianamente dalla chiesa, addomestieando questo per ‘o 50 in una sorta di rappresentazione teatrale, poi fissata in una pittura compendiaxia? Questa possibilità potrebbe cogliersi nella coesistenza rituale di simboli dotti., i clipei crociate e della parola scritta, e simboli folklorici, asinello, oca, lupo, zampa d’oca e della parola pronunciata (contrapposizione-coesistenza tra orale e scritto).
Ma chi sono gli autori-attori di questo atto penitenziale?, di questo processo di erudizione di un rito folklorico? Barusone e Dorgotorio Pinna. Non sicuramente parla, io dimostra l’uso disinvolto della scrittura, la capacità dei riferimenti simbolici plurrisemantici, lo dimostra il fatto che a loro si deve la testimonianza dell’avvenuta consacr zh .n. della chiesa..
Il fatto che ci troviamo di fronte a due donnos che assieme intraprendorso un der poenitenziale, oltre a ricordarci la figura dei due templari che condividono lo stesso cavallo, ci ricorda il "compagnonaggio" dei milites.Christi, attraverso il quale si instaura, com.e afferma Franco Cardini, l’equilibriò del perfet o :av iere, che deve possedere "due dLoti. complementari, Prouesse e Sagesse, Fortitudo e Sapientia", doti che per i cavalieri templari dovevan g rimogliare sul substrato etico della loro prima vocazione penitenziale.
Per quanto riguarda Barusone e Dorgotorio Pinna, figure di "donnospaperos" (?) (pauperos), qualcosa di più si sarebbe potuta sapere e trarre attraverso le iscrizioni se, sfortunatamente, non fossero così franurnent ‘e. Una cosa, però, si può sicuramente notare: abbiamo già accennato alla lettera iniziale della terza iscrizione, la E di Ego (Ego Dorgotorio Pinna ...). Questo segno ricorda lo scudo di un cavaliere templare graffito nel donjon di Chinon 12,
I nomi di per sé possono informarci poco, anche perché nei Condaghi si ritrovano ripetuti spessissimo, e molti sono i casi di omonimia. Ad esempio un Dorgotori Pinna è citato in quattro schede delL Condaghe di San Pietro di Silki (XI-XIII sec.), in quel Condaghe cioè, dove sono no atri maggiormente i Cavalieri Templari. Il periodo è quello in cui reggeva il monastero femminile la badessa Massimilla, essendo priora Susanna Pinna14
Sicuramente possiamo stabilire che sono personalità di un certo rango, maiorales, donnos, che possono permettersi l’edificazione di una chiesetta, ornandola di pitture. Specifichiamo che col termine donno-donnu venivano denominati non solo i giudici e i nobili membri della loro famiglia, ma anche ecclesiastici, arcivescovi, vescovi, abbati, monaci. Interessante a questo proposito la scheda 188 del Condaghe di San Nicola di Trullas: "Kertarum meco sos de Ospitale, donnu Cera rdu et Taiaferru", e la scheda 305 "...et donnu Furatu Solina prebiteru dessu Templu . » (trattasi di un templare, lo stesso può riferirsi per la scheda 247, in cui si cita, tra i testimoni, Johanne dessu Templu). In un documento relativo ad una donazione (1113) fatta da Petru d’Athen, alla chiesa di San Nicolò, si legge: "istud permaneat ibi in sempiternum, et quantum habet remanere dessa antiga de regimenriu dessos clericos ci habent essere in Sanctu Nicolaum per issos donnos de ..arnaid a, volumus et desideramus pro Deum e pro Sancta Karitate ci non vajat in altra parte, ne olio opus, nibi vestimenta et calciamenta dessos donnos heremitas ci vi sunt como in su eremu et ibi habent essere e restare" 16
Per quanto riguarda Norbello v’è da sottolineare, inoltre, la precisa scelta di eseguire le iscrizioni in corsivo, fatto che evidenzia oltre alla familiarità con quel tipo di scrittura, un intento volutamente più caratterizzante dell’atto penitenziale, caricato dell’impronta personale lise o scritto. Si può forse intuire, o ipotizzare, una distinzione di ruoli tra Barusone e Dorgotorio; Barusone è investito della facoltà che permette di consacrare l’edificio: "Ego Barisone Pinna que sacrate...", manca la definizione di una carica ecclesiastica canonica, quale troviamo, ad esempio, nella scheda 305 succitata. Ricordiamo, però, che 1129 marzo 1139 il papa emanava la bolla Omne datum optimum, con cui i templari ebbero cappellani e l’autorizzazione ad edificare cappelle e oratori. Rimane da chiedersi, infine, il perché della necessità di quel particolare rito. U]rm pa a malattia?, lupus-lebbra?, voto al ritorno da un pellegrinaggio?, trasgressione ad una norma sociale o religiosa? Il pellegrinaggio penitenziale interiore, "sostitutivo" di quello reale, veniva atrua. to per sciogliere un voto, o anche per imposizione giudiziaria in segu. o ad una ione ill cita. A Norbello questo tipo di pellegrinaggio si esplicita materialmen con la cos zione della hiesa e spiritualmente nel rituale.
D’altra parte il pellegrinaggio ad Loca Sancta non veniva praticato solt to da importanti personaggi: ricordiamo Gonario Il di Torres che oltre al pellegrinaggo in Terra Santa: "andavat a Jerusale" - visitò "ateros logos santos"; che a Gerusalemme s r o, dopo il 1161, il giudice Costantino di Cagliari; o il voto fatto nel 1220 dal giudice Mariano II di Torres di recarsi al Santo Sepolcro, e quello fatto da suo padre Comita, poi sciolti con l’invio nel 1221 del vescovo di Sorres, di venti militi e una somma di denaro. E ancora, che tra il 1343-46 il giudice Pietro III d’Arborea intraprese per tre volte il viaggio in Palestina; e che Mariano IV, succeduto sul trono d’Arborea nel 1347 al fra elio Pi t o III promise a santa Caterina da Siena, che preparava una grande crociata in Terra Santa, di concedere due galee, mille cavalieri, tremila pedoni e seicento armati, per die. :1 anni, il sovrano però non potè adempiere questa promessa. Ma anche persone comuni A fa e vano pellegrini. Ne sono prova, la presenza a Roma, per il Giubileo dei 1350, di tre pellegrini sardi, ricordata nel VI volume dei Procesos contra los Arborea e la scheda del Condaghe di San Pietro di Silki: "Posit Furato de Var(c)ca a cclesia su ki vi aveat in cuniatos de Sanctu. Janne in s ‘Olivellu, cando andavat ad Jerusalem...", va ricordata, inoltre, la scheda 96 dove si nomina "donnu Petru de Serra de Jerusale".
Al pellegrinaggio ci si preparava (i grandi personaggi, si pensi a san Luigi di Francia, come le umili persone) penitenzialmente regolando i propri beni, con donazioni, riparando i torti commessi, facendo testamento 19· Spesso tutto questo comportava io scioglimento di un voto, dovuto per esempio ad una scampata malattia, come si può leggere nelle schede 256 e 359 del Condaghe di San Pietro di Silki, o in quelle 160, 218 del Condaghe di San Nicola di Trullas, e in quella 148 del Condaghe di Santa Maria di Bonarcado.
Ma, ai di là di queste possibilità, quale sottile filo lega, in uno stesso rito penitenziale, i simboli dei clipei crociate alle figure di animali in processione dipinti a Norbello?
Ed ancora, il rito prevedeva testimoni multis videntibus (o per dirla con la lingua dei Condaghi et alias multos ), come avveniva per gli atti documentari, oltre che per i rituali ecclesiastici o laici, investiti di sacralità, osi svolgeva in una sorta di solitudine iniziatica? Dall’ articolo 361 della Regola dei templari sappiamo che particolari processioni rituali avvenivano in privato: "E si fanno nel tempio altre processioni che si dicono private, poiché sono compiute privatamente dal cappellano, dal sacerdote e dal chierico, senza gli altri fratelli.. .Tuttavia se la processione attraversa luoghi che di norma sono preclusi ai fratelli, i fratelli possono andare in processione solo se hanno ricevuto il permesso".